
Nel precedente articolo, Sarà mai possibile viaggiare fra le stelle? Seconda parte, abbiamo illustrato le singolari idee di due scienziati, Miguel Alcubierre e Serguei Krasnikov, esperti di relatività generale, i quali sostengono che un'opportuna deformazione dello spazio-tempo consentirebbe ad un veicolo spaziale di viaggiare più veloce della luce. Abbiamo anche visto che un "ingrediente" fondamentale per creare sia la bolla di curvatura di Alcubierre che il tunnel di Krasnikov è l'energia negativa. Ora, in questa terza ed ultima "puntata" sui viaggi interstellari, cercheremo di capire quanta energia (negativa e positiva) sarebbe necessaria per viaggiare nello spazio nei modi descritti dai due fisici. Scopriremo inoltre che la relatività generale ci consente altri prodigi, come viaggiare indietro nel tempo e racchiudere un oggetto macroscopico in uno spazio microscopico, ed infine esamineremo altri modi teorici di superare la velocità della luce.
ATTENZIONE: quello che hai appena letto è solo un estratto, l'Articolo Tecnico completo è composto da ben 2650 parole ed è riservato agli ABBONATI. Con l'Abbonamento avrai anche accesso a tutti gli altri Articoli Tecnici che potrai leggere in formato PDF per un anno. ABBONATI ORA, è semplice e sicuro.



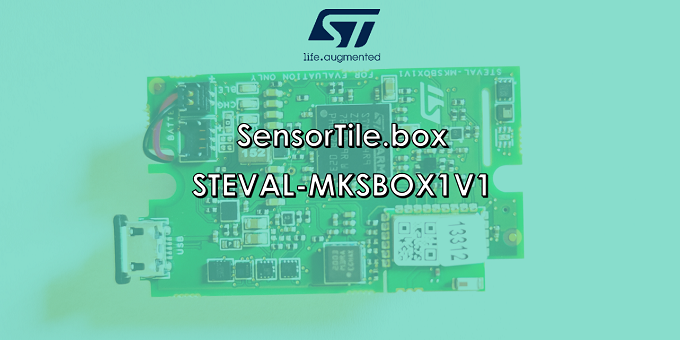
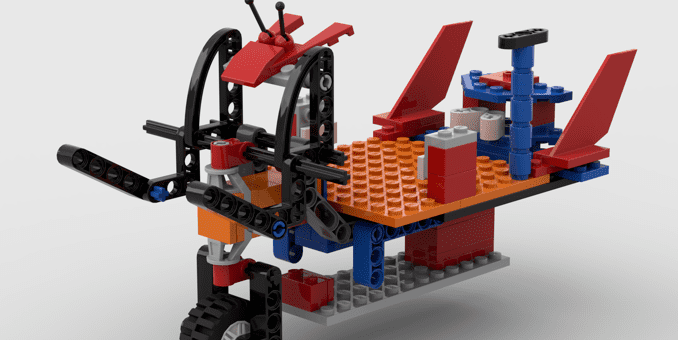
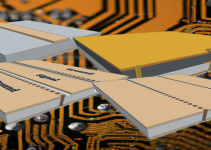


Voglio fare i miei più sinceri complimenti a Marco per questo articolo.
L’ho trovato semplicemente bellissimo.
Stimolante, nuovo e completo, ora che ha chiuso la terza puntata.
Ci sono sicuramente tante domande che si possono fare, tante cose da chiedere e tanti dubbi da sollevare, specie per chi, come me, sull’argomento è un po’ a digiuno.
Io nel frattempo me lo rileggo 🙂
Non ho capito una cosa sulla bolla e sul suo spessore. Quanto sottile?
Quando dici che l’energia sarebbe inferirore di quella calacolata da Ford, di quanto? Ed è la soluzione?
Per la (2) lo spessore dell’involucro della bolla (Δ) non deve superare il valore 100 × vb × lunghezza di Planck. La lunghezza di Planck è circa 1,616 × 10^-35 metri, quindi se la bolla viaggiasse ad esempio al decuplo della velocità della luce (vb = 10), Δ non potrebbe essere più di 1,616 × 10^-32 metri = 1,616 × 10^-23 nanometri.
Se non valesse la (2), come alcuni ricercatori sostengono, Δ non dovrebbe essere necessariamente così piccolo e, per la (4), si potrebbe ridurre E aumentando Δ (ad esempio, per Δ = 1 metro, E si ridurrebbe all’incirca a 1/4 della massa del Sole). Infatti, studiando la funzione E(Δ) data dalla (4) si scopre facilmente che è una funzione sempre negativa definita per Δ > 0, che tende a -∞ per Δ che tende a 0, cresce da 0 a √12×R (punto di massimo) e poi decresce tendendo a -∞ per Δ che tende a ∞. Quindi √12×R sarebbe il valore di Δ che minimizzerebbe la quantità di energia negativa E se non valesse la (2).
Grazie Piero. Questi 3 articoli li ho redatti veramente con grande entusiasmo, passione ed impegno, e probabilmente sono ciò che di meglio ho prodotto da quando collaboro con EOS, anche se purtroppo hanno suscitato molto meno interesse di quanto mi aspettavo.
Hai perfettamente ragione quando asserisci che un simile tema solleva molti dubbi e domande. Come ho già detto, ci si potrebbero scrivere libri interi. E a tal proposito, se tra i lettori di EOS c’è qualche studente di fisica o matematica interessato alla relatività, gli suggerisco caldamente di scegliere questo come argomento della sua tesi di laurea o dottorato.
All’interno dell’articolo, ho dimenticato di precisare che le 2 traduzioni (le 2 porzioni di testo in corsivo virgolettate) non sono opera mia ma di Michele Diodati, l’autore dell’articolo “Viaggiare più veloci della luce: motori a curvatura e metro interstellari” presente nella bibliografia. Era doveroso da parte mia fare questa precisazione.
domanda; visto la forte quantità di energia che serve, senza contare le forze di accelerazione e di decelerazione, essendo il cosmo un ambiente ostile come ci si protegge soprattutto dalle radiazioni?
Altra domanda; come ci si orienta in uno spazio così grande e chi sa che mappatura e in tridimensione forse più di una dimensione?
I componenti elettronici e gli eventuali occupanti di un veicolo spaziale vengono parzialmente protetti dalle radiazioni tramite una schermatura in alluminio, che è leggero (mentre ad es. il piombo è troppo pesante per essere usato in tali veicoli). Si stanno studiando metodi di schermatura più efficienti, come ad es. una sorta di “scudo magnetico” ossia un dispositivo che generi un campo magnetico attorno al veicolo atto a deflettere le radiazioni.
Presumo che l’unico modo per orientarsi nello spazio interstellare sia quello di usare sensori analoghi ai sensori stellari dei satelliti (http://w3.uniroma1.it/digiamberardino/didattica/Mis2008_2009/Files/Sensori%20d'assetto.PDF), ovvero sensori che osservino l’ambiente esterno e lo confrontino con mappe stellari memorizzate nel computer dell’astronave. Immagino che sarebbe molto utile se non indispensabile inserire nel computer anche dati inerenti la stella verso cui ci si vuole dirigere in modo da poterla individuare mediante appositi sensori. Tutto ciò, per ovvi motivi, sarebbe ben più arduo se l’astronave viaggiasse deformando lo spazio-tempo.
Ho appena terminato di leggere questa affascinante trilogia sul viaggio nel tempo… Rimango sempre senza parola quando leggo i suoi articoli,ancor di più con questa… Davvero una magnifica pubblicazione…
I miei più sinceri complimenti
Leggere questi articoli come articoli di “scienza”, e non come
fantascienza mi ha davvero fatto capire quanti progressi stia
facendo l’uomo.
Credo di aver visto tutta la vecchia serie di “Start Trek”, e molto
delle serie successive.
Lettore di Urania, inseme a Franco e Francesco 2 miei amici,
avevamo raccolto e collezionato tutti i numeri di Urania fin dai
primissimi introvabili e pagati a caro prezzo.
Lettore di fantascienza Asimov il ciclo della Fondazione, le leggi
della robotica ecc…
Tutto era rimasto fanta…. ora con questi articoli simo passati a
parlare di Scienza con la C maiuscola.
Non ho certo potuto seguire e comprendere i vari passaggi
matematici, ma dalle conclusioni si comprende che la strada è stata
imboccata che il cammino sarà lungo o lunghissimo ma il desiderio
dell’uomo di esplorare l’universo lo guiderà in questa impresa.
Passerò a Franco questo articolo ( Lui ha conoscienze matematiche
per apprezzalo al meglio.)
quindi al motto “Arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima”,
teniamo la mente aperta pronti a cogliere le nuove opportunità.
Grazie per questa trilogia.
Sergio.
Ringrazio infinitamente Domenico e Sergio. Non ho mai ricevuto in vita mia complimenti così gratificanti come quelli che mi fate voi lettori e colleghi di EOS. 🙂
che bell’articolo…semplice per quello che può esserlo un tema così complesso e affascinante, soprattutto a quella generazione che ini strar trek vedeva una idea di come sarà o meglio potrebbe essere il futuro certo non in una missione quinquennale,,,,,,ma che ha aperto le menti a cercare nuove forme e nodi di sviluppo forse troppo poco sostenuti da ottusi “POLITICANTI” capaci solo di reprimere e imbrigliare la pura ricerca…..
bellissima trilogia.
grazie grazie grazie
Danilo
Grazie a lei, a tutti voi che avete apprezzato il mio lavoro.
Come ho già affermato, questi 3 articoli sono probabilmente quelli in cui ho profuso più impegno, passione ed entusiasmo, essendo quello dei viaggi spaziali un tema che ha da sempre esercitato un incommensurabile fascino su di me.
Per quanto riguarda invece i politicanti, magari quella di non agevolare il progresso scientifico e tecnologico fosse la loro unica colpa.