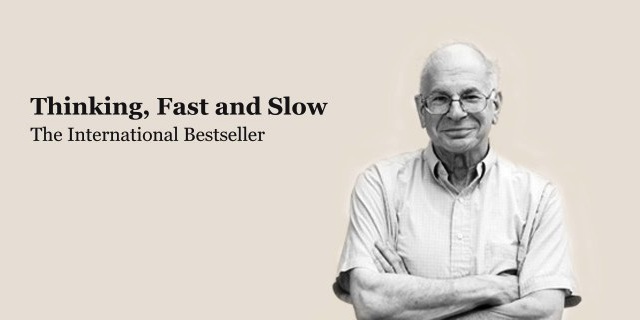
Articolo ispirato dal bestseller "Pensieri veloci e lenti" di D KAHNEMAN - psicologo premio Nobel economia. Bisogna stare attenti: le nostre abilità (certo utili) di intuire cose facili ci traggono in errore, anche se sappiamo tanto su qualche argomento. Discuto la questione e non sono del tutto d'accordo con Kahneman, anche se ha analizzato bene (in modo sorprendente) il funzionamento della nostra mente e mi ha fatto capire molte cose. Non è sorprendente che si possano avere idee difformi, dato che mente e cervello sono molto complessi.
Le intuizioni degli esperti sono migliori?
Alcuni di noi qualche volta intuiscono verità nuove o eventi futuri. In ogni campo, riesce meglio a farlo chi è più esperto. Riconosce situazioni che ha già visto. Individua effetti imminenti di certe cause. Per capire quello che accade intorno a noi e prevederne gli sviluppi è ragionevole chiedere agli esperti, purchè non siano solo sedicenti..
L’errore è sempre in agguato. Se spesso un certo evento ne precede un altro, tendiamo a concludere che il primo è la causa del secondo, anche se non è così. Se due grandezze variano di concerto, diciamo che sono correlate.
Se la proporzionalità è esatta, la correlazione vale 1. Se è approssimativa, vale meno di 1. Se le due grandezze crescono o calano in modo del tutto indipendente, la correlazione è zero. Se una è inversamente proporzionale all’altra, la correlazione vale -1.
Secondo alcuni si dovrebbe proibire il calcolo delle correlazioni statistiche. La correlazione fra il numero di PC usati in Italia e il numero di morti per AIDS dal 1981 al 2004, era molto alta: ben 0,99. Infatti in quegli anni numeri crescenti di italiani compravano personal computer e, intanto, prima centinaia, poi migliaia di loro morivano di AIDS , ma i fenomeni non avevano relazione fra loro.
Sono rari gli esperti capaci di intuire i rapporti di causa ed effetto e di descrivere quello che succederà, se si parla di situazioni complicate.
Ce ne rendiamo conto se proviamo a intuire il risultato di un problema semplice:
“Una racchetta più una palla costano 1,10 Euro e la racchetta costa un euro più della palla. Quanto costa la palla?”
La maggioranza degli interpellati, anche colti, risponde: “10 centesimi”. Ma, allora, la racchetta costerebbe solo 90 centesimi più della palla. Usando l’algebra, si vede subito che la risposta giusta è 5 centesimi. Traggo l’esempio dal best seller di Daniel Kahneman "Pensieri lenti e veloci". È un libro interessante - e discutibile. L’autore è lo psicologo che nel 2002 vinse il Nobel per l’economia: studiando i modi in cui saltiamo alle conclusioni.
La nostra mente lo fa usando il Sistema 1 - la funzione rapida e intuitiva che ci serve di continuo per risolvere problemi facili e usuali. Il guaio è che spesso a usiamo questo sistema anche per problemi più difficili, per i quali dovremmo usare invece il nostro Sistema 2, la funzione mentale metodica e razionale, che è in genere pigra e lenta, anche se ci siamo addestrati a perfezionarla. Anche gli esperti danno spesso giudizi frettolosi e sbagliati. .
Kahneman analizza i meccanismi con cui raggiungiamo conclusioni. Fattori inconsci e irrilevanti pilotano spesso le nostre decisioni, reazioni e opinioni. Alcune osservazioni di Kahneman suonano sorprendenti, ma poi ci accorgiamo che sono centrate. Il nostro arbitrio non è tanto libero. Siamo soggetti agli stimoli esterni - e quasi ci viene da vergognarcene.
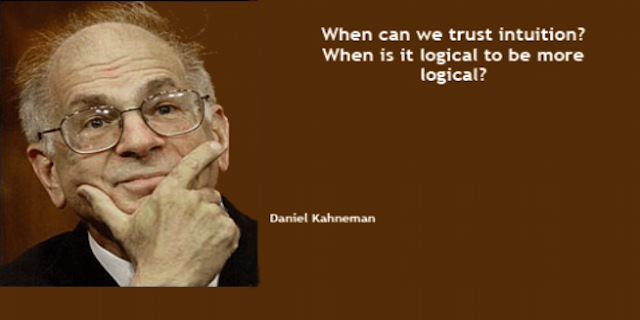
Ragioniamo meglio se assumiamo un’espressione seria e concentrata. Meno bene se facciamo una faccia buffa. Diamo risposte più ottimiste, se tiriamo i muscoli delle guancie come se sorridessimo. Già molti anni fa un noto psicologo chiedeva: “Piangiamo perché siamo tristi – o siamo tristi perché piangiamo?” – era un precursore.
Se si chiede “la sequoia più alta supera 360 metri di altezza?” la media degli interrogati stima l’altezza massima in 250 metri. Se si chiede: “la sequoia più alta supera 85 metri di altezza?” la stima media scende a 60 metri.
Se ascoltiamo o leggiamo parole attinenti alla vecchiaia, poi tendiamo a camminare più lenti - “da vecchi”.Molti giudici emettono verdetti più favorevoli agli imputati dopo aver fatto una buona colazione.
Le immagini e anche la sola menzione di eventi o situazioni drammatiche inducono molti a esagerarne l’importanza. I sondaggi dello psicologo Paul Slovic mostrano che, in genere, il pubblico ritiene gli incidenti causa di tante morti quanto le malattie (mentre ne causano 18 volte di meno). Stima che gli uragani uccidono più dell’asma (che è 20 volte più letale). Kahneman dice: “La stima delle cause di morte è quasi una rappresentazione diretta dell’attivazione di idee nella memoria associativa - la facilità con cui sorgono alla mente le idee dei vari tipi di rischio è strettamente legata con le nostre reazioni emotive a questi rischi e influenza le nostre opinioni.
Io ho studiato ingegneria dei rischi e so a memoria le percentuali delle cause di morte in vari Paesi ed epoche. In particolare so che negli anni Settanta in Italia morivano in incidenti stradali 12.500 persone l’anno circa il doppio di quelli che morivano per cadute accidentali mentre oggi le vittime di incidenti stradali sono meno di 4.000 e quelle per cadute sono salite a 10.000. Ho vissuto in California e ricordo bene che le sequoie più alte arrivano a circa 100 metri - pare che la più alta sia di 116 metri.
Certo il caso influisce su molti eventi. Quindi ogni previsione che facciamo è affetta da incertezza. Però gli esperti esistono, per fortuna, e molti di loro ricordano bene il passato e il presente - nel loro campo - e riescono a prevedere quello che sta per succedere. Quando hanno fortuna, riescono a prevedere anche l’avvenire meno immediato. Se prevedono i prezzi futuri di azioni, metalli preziosi, gas o petrolio, mietono profitti notevoli.
Il modo più semplice di fare previsioni è quello di extrapolare. Se qualche cosa sta crescendo, sostenere che continui a crescere; se cala, che continui a calare. Non ci vuole molta scienza.
Le previsioni accurate le sanno fare i fisici quando si occupano di eventi misurabili e individuano cause ed effetti. Quando ci occupiamo di situazioni socio-economiche, di azioni umane intraprese da grandi numeri di persone, le cause sono numerosissime e molte di esse non si possono misurare con precisione. Economisti e psicologi riescono a individuare regolarità e rapporti fra grandezze e parametri. Ne possono dedurre anche formule e modelli matematici che, però, non hanno validità assoluta e non permettono di sapere che accadrà fra anni, decenni, secoli. Invece alcuni pretesi esperti si azzardano a extrapolare tendenze al cambiamento dal breve periodo a intervalli di tempo molto più lunghi.
Lo fece R Malthus nel 1830: notò che per 40 anni la popolazione USA era cresciuta del 3% all’anno e concluse che tutte le crescite di popolazione siano esponenziali. Invece molti processi di sviluppo o declino si possono descrivere (producendo proiezioni plausibili e spesso accurate) con le equazioni di Volterra. Esse descrivono l’evoluzione di popolazioni biologiche, di epidemie, di prodotti e di variabili come: consumi elettrici, mobilità, etc. Tali equazioni definiscono le curve logistiche a S: tipicamente una popolazione comincia a crescere lentamente partendo da valori minimi. Poi accelera sempre più fino a sembrare esponenziale. Quindi rallenta gradatamente quando entrano in azione fattori limitanti e, infine, raggiunge un valore massimo costante, detto asintoto.
Si possono costruire anche modelli matematici di grandi fenomeni complessi: l’economia mondiale (o nazionale o aziendale), il clima, le vicende politiche. La capacità previsionale di questi strumenti è molto minore di quella dei modelli prodotti dai fisici. Spesso si rivela nulla dopo pochi mesi o anni. La struttura di questi modelli può anche essere esteticamente gradevole. Però non bisogna innamorarsene, né pretendere di calcolare quello che succederà fra decenni o secoli.
I modelli razionali e quantitativi sono prodotti dal citato Sistema 2, che è uno strumento meraviglioso, sofisticato - e ancora misterioso. Il nostro cervello è ben più complesso della dicotomia di Kahneman e anche della tripartizione di Freud fra id, io, super-io. Mentre i neurofisiologi continuano a capirlo sempre meglio, noi – utenti finali – possiamo usarlo empiricamente e addestrarci a intuire regolarità e tendenze. Dobbiamo essere pronti a riconoscere l’errore, sempre in agguato, e rassegnarci a cercare ignotum per ignotius.
Leggi gli altri articoli del Blog di Roberto Vacca


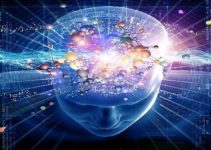


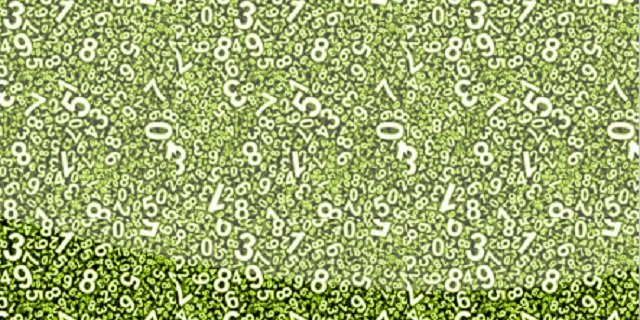

Una riflessione davvero affascinante.
E devo dire che talvolta anche condivisa…
Mi son trovato in diverse situazioni a ragionare in questo modo e soprattutto i due esempi, sulla rachhetta da tennis e sul rapporto causa effetto tra pianto e tristezza, sono motivo di grandissimi ragionamenti.
Il primo perchè non è mai un caso se gli indovinelli son fatti in una certa maniera. Ragionare vuol dire metterci del metodo nelle cose, non fare d’impulso. Ma è anche vero che l’intuizione stessa è impulso. E allora la mente geniale che fa? Vive di metodo o di impulso?
Alla fine, per me, la verità è che deve vivere di un forzato ed autoindotto equilibrio tra le due.
La seconda è ancora più interessante.
E mi fa pensare anche allo sbadiglio.
Sapete che non è ancora assolutamente scientificamente provato oltre ogni dubbio quale sia la sua funzione, la sua stessa eziologia…
Sbadigliamo perchè abbiamo sonno e gli altri rispondono? O abbiamo sonno e sbadigliamo per manifestarlo? Io per primo sbadiglio spesso se ho fame, freddo…
Allora lo sbadiglio non è univoco (ed anche questo è parte di un’ipotesi complessiva).
E comunque questo non spiega perchè in una stanza se uno inizia a sbadigliare, tempo due secondi lo fanno tutti, senza distinzione di sorta, anche chi non guardava…
Ciao Piero, una volta ho chiesto a un dottore la causa dello sbadiglio, e mi ha affascinato la sua risposta. Semplice, banale, ma mi ha colpito proprio perché lo sbadiglio è un elemento con del mistero.
Mi ha detto: quando il cervello ha bisogno di più ossigeno si innesta una reazione nel corpo che corrisponde allo sbadiglio, che permette una più veloce iniezione di ossigeno nel corpo.
Ma ora ho ancor di più il dubbio che assale anche te… allora perché è così tanto contagioso?!?!?!
il tema è interessante ma troppo complesso!
Per coloro che provengono dalla 'teoria dei sistemi' il metodo per mitigare il portato delle "intuizioni semplici e geniali" è l'applciazione del concetto di analogia con il quale mutuare modelli che hanno dimostrato di funzionare in un dato contesto verso nuovi campi applicativi dove detti modelli non risultano ancora applicati (stando molto attenti).
un saluto e grazie per l'occasione di meditazione
Antonio
Davvero bell’articolo. Un argomento che fa riflettere molto.
In particolare mi fa pensare a 2 cose:
1 – spesso ci affidiamo ciecamente a degli esperti, come se fossero dei guru che, in quanto esperti, sarebbero i detentori della Conoscenza e incapaci di sbagliare
2 – ancora più spesso ci scandalizziamo quando un esperto commette un errore
Questo succede perché si sottovaluta la complessità della mente, e facciamo semplici suddivisioni: genio o incompentente, buono o cattivo, etc… spesso con raggruppamenti di categoria.
La mente umana è davvero un grande mistero, e spesso tendiamo a ridurre fin troppo la sua complessità.
…a mio modesto parere, si è sempre più propensi a commettere errori, ogni qual volta la propria preparazione, in merito ad un dato argomento, è sempre crescente, o assolutamente elevata, tale da indurci a pensare di essere dei competenti in materia. In poche parole, se sono consapenvole di essere un "esperto", in un dato settore, sono sempre più a rischio di commettere errori semplicemente perchè parlo più spesso e tendo a riflettere meno rispetto a colui che potrebbe avere una minore preparazione in merito rispetto alla mia.
Un esempio lampante, l'introduzione dell'euro.
Quanti esperti ci hanno raccontato, al tempo, che sarebbe stata la più grande conquista economica dell'europa fatta dall'epoca dell'introduzione dell'UE?
Ora quanti di quegli esperti sarebbero pronti a riaffermare ciò?
La loro esperienza ha giocato un brutto tiro, il non riflettere sulla semplicità della moneta come misura del valore nonchè valore della misura di un bene o di un servizio.
..e le conseguenze di ciò.
Spesso, più siamo consapevoli della nostra esperienza e conoscenza, più dimentichiamo le tabelline.
Quindi la parola d'ordine, a mio avviso è UMILTA' nel ragionamento e nel porsi rispetto agli altri interlocutori.
Personalmente credo che la cieca fiducia rischia di portarci in errore, così come la cieca mancanza di fiducia rischia di portarci in errore.
Questo non vuol dire dubitare degli esperti.
Esempio: hai bisogno di operarti. In quel momento dai la tua fiducia al medico (giustamente, non puoi mica operarti da solo…). Magari prima cerchi il migliore (di nuovo giustamente, soprattutto se l’operazione è delicata).
Ma credere che solo perché è il migliore non esistono probabilità di errore, ecco, questo credo che non sia la cosa giusta. Intanto perché è una persona umana. Poi perché come definisci il migliore? In base al minor numero di errori rispetto alla totale casistica, ad esempio.
Le mie conclusioni le puoi trarre da solo a questo punto.
Voglio dire che fidarsi degli esperti non è un errore in se per se. Ma dare per certo che un esperto non possa sbagliare è tutt’altra questione.
Così come dare per certo che una persona che noi reputiamo non esperta non possa invece fare cose notevoli.
Riguardo alla fisica quantistica… così come tante altre questioni, dopo che un esperto si pronuncia, ci sono sempre tantissimi esperti che cercano di dimostrarne la veridicità o confutarla. Ma stiamo davvero parlando di altro… si parla di questioni definite “a bocce ferme”, l’articolo e il mio commento si riferiscono ad altro.
Anche io ho notato questa cosa. Solo che non ho capito se tu hai un’idea sul perchè sia contagioso o no.
Ma se ci mettiamo a dubitare degli esperti non andremo mai più da nessuna parte.
Alla fine io non sono mai stato in egitto ma gente erudita mi ha detto che ci sono le piramidi lì e io ci credo.
Con questo ragionamento la fisica quantistica sarà per sempre una panzana.. o no? 🙂
Che c’entra l’euro adesso???
Tra l’altro poi l’euro è una moneta, un oggetto inanimato, che quindi non può in nessun modo essere buono o cattivo. Per definizione.
Come tutti gli strumenti in mano alle persone, sono le persone che fanno cose che sono buone o cattive e non le cose.
Le pistole sono pericolose ma da sole non sparano.
Le macchine possono investire ma non si guidano da sole.
Potrei continuare ore ma penso il concetto sia chiaro!
Una volta tanto, siamo perfettamente d’accordo. 🙂
L’analisi sull’euro, specie quella che viene fatta da taluni esponenti della politica italiana oggigiorno, è parziale, faziosa e condotta con immaturità ed incompetenza suscitando ed eccitando l’onda emotiva più becera e miope.
Tra l’altro ignorando e tacendo il fatto che l’euro come moneta fa parte di un progetto politico ben più ampio che ci vuole tempo e determinazione politica continuativa a costruire.
Un’idea globale, complessiva, rivoluzionaria che necessita di spostare l’attenzione dal piano della governance finanziaria fine a se stessa a quello dell’indirizzo politico costituente.
Un progetto magnificente il cui scopo è quello di eliminare barriere di fatto all’integrazione verso il quale sarebbe il caso che ognuno di noi nutrisse un certo rispetto…
E mica finisce qui perchè anche quello che sto scrivendo è parziale, incompleto e, ahimè, trattato comunque con un enorme margine di impreparazione rispetto ad una serie di questioni sulle quali, necessariamente, ahimè, non sono specializzato.
Per quanto io legga e provi a studiare in merito non mi sento un “esperto” 😉
Detto questo, credo che nessuno di noi possa in tutta onestà pensare che una pistola spari da sola per cui la risposta è evidentemente “no, l’euro non è affatto cattivo”.
E trovo questo esempio davvero calzante e pertinente!
Come pochi altri.
Resta comunque che deve con urgenza riprendere quel processo costituente arenatosi diverso tempo addietro.
Non dubito che per tutti noi la tappa del 25 maggio possa certamente essere fondamentale. E a tal proposito sono sicuro che, in coscienza, tutti sapremo optare per il meglio (sempre secondo coscienza).
Carissimo Piero.
Questo tuo ultimo commento sull'Euro è la prova provata che se non si capisce un accidente su qualcosa è meglio stare zitti.
Direi che in linea con le tesi dell'articolo.
Io preferisco credere a Krughan (premio Nobel per l'economia) e a moltissimi altri economisti di valore che da anni ci stanno dicendo che l'euro è la morte dell'Europa e dell'Italia in particolare.
Grazie all'euro in Grecia è aumentata la mortalità infantile perchè lo Stato non può più spendere per la salute. Sono alla fame. Ci sei stato in Grecia recentemente? IO SI!!!
La disoccupazione in Italia, Grecia e PIIGS è spaventosa, la povertà è esplosa (chiedi ai gestori di Caritas &C), i suicidi di piccoli imprenditori in impennata.
Gli stati NON possono spendere perchè l'euro LO COMPRANO A INTERESSE DA BANCHE PRIIVATE!!!!!!!!!!!!!! Lo sapevi questo Piero? E poi sono bloccati dal 3%.
E il 3% SAI DA DOVE VIENE? Ecco l'articolo del Sole 24 ore che qualcosa piu di te capisce:
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-01-29/parla-inventore-formula-3percento-deficitpil-parametro-deciso-meno-un-ora-102114.shtml?uuid=ABJHQ0s
E chi sono i tuoi "…taluni esponenti della politica italiana oggigiorno, è parziale, faziosa e condotta con immaturità ed incompetenza suscitando ed eccitando l'onda emotiva più becera e miope.." Chi sono i demagoghi? Grillo?? La Lega??? Per continuità della tua dotta dissertazione faccelo sapere…
Il 25 Maggio gli Italiani, se non plagiati troppo da TV e giornali di regime, sapranno cosa fare
L'euro E' UNA PISTOLA CARICA e la Germania ha il dito sul grilletto.. Distruggendo l'Italia ha eliminato un suo diretto competitor.. NOI! Bisogna essere ciechi (o.. qualcosa di peggio) per non vedere tutto questo.
Comunque a me interessa una pubblicazione di elettronica. Se vuoi scrivere di politica fallo dalle pagine de "L'Unità" o meglio di "Repubblica" che magari ti riconosce anche un gettone per il tuo valido contributo
Magari t’è sfuggito un punto: Piero è intervenuto su una risposta a me che ho risposto ad alessio31183.
E comunque, che ti scaldi a fare?
La discussioni ha preso una piega che non riguarda l’elettronica.
E allora?
Qua stiamo parlando e non c’è bisogno di fare tanta caciara.
Innanzitutto buongiorno.
Dunque, vediamo di fare un po’ d’ordine perchè mi pare evidente che ce ne sia una discreta urgenza.
Prima di tutto, su questo sito la politica non è un argomento proibito.
Diciamo però che ci piace rimanere sul tecnico quindi sarebbe il caso di tornare in quest’alveo.
Ciò nondimeno, i commenti esistono proprio perchè gli utenti TUTTI sono liberi di esprimere le loro opinioni con la massima libertà e nel rispetto delle opinioni degli altri.
Tra l’altro è l’articolo in sè, mi pare, a fare proprio questo.
Pertanto, qui OGNUNO ha diritto di esprimere la propria idea ed è bello ed utile che le discussioni prendano pieghe differenti sulla base di ciò che ciascuno vuole portare come contributo.
E questo, naturalmente, vale sempre e solo SE lo si fa in maniera costruttiva e senza alterchi di qualsivoglia natura.
Intendi adattare i modelli a casi differenti ma non troppo?
A tal proposito, vorrei riprendere proprio un passo dell’articolo:
“si dovrebbe proibire il calcolo delle correlazioni statistiche. La correlazione fra il numero di PC usati in Italia e il numero di morti per AIDS dal 1981 al 2004, era molto alta: ben 0,99. Infatti in quegli anni numeri crescenti di italiani compravano personal computer e, intanto, prima centinaia, poi migliaia di loro morivano di AIDS , ma i fenomeni non avevano relazione fra loro.”
La correlazione è uno strumento potentissimo!
E non è vero che non esista in sè.
Ma si tratta di un’ipotesi che deve essere verificata e per farlo c’è urgenza di fare supposizioni di correlazione relistiche.
Questo è un esempio di correlazione assolutamente stupida.
Ma se uno fa un’analisi su come cambia il tenore della spesa quotidiana sul cibo ed il calo del potere d’acquisto della moneta che ha in tasca, oppure proprio un’analisi di correlazione sul caso preso ad esempio in precedenza, allora sì che la statistica diventa utile! 😉
Ricordati sempre, però, che la statistica è quella materia secondo la quale “se io mangio 2 polli e tu mangi 0 polli, tutti e due abbiamo la pancia piena perchè abbiamo 1 pollo a testa”…
Cerco di spiegarmi meglio: la statistica in sè e fine a se stessa non è una cosa utile perchè è un modo per standardizzare qualcosa che non è standard.
La statistica cerca di inscatolare dentro criteri descrittivi una realtà poliedrica, smussandone le differenze.
E questo, in sè, è la morte proprio di quelle differenze sostanziali che rendono tutto così vario e bello da vedere e scoprire.
Bisogna sempre approcciarsi con una certa circospezione alla materia.
Ti faccio un esempio: supponiamo che esista una statistica che dica quanto si sbaglia un medico.
Diciamo che si valuta il fatto che l’operazione sia riuscita o meno.
Qui non si tiene traccia del fatto che il chirurgo sia stato 12 ore in sala oppure solo 2. Si valuta solo “si” o “no”.
Certo, l’utilità per il paziente è questa ed è lui che va tutelato.
Ma se un medico è costretto a stare 12 ore in piedi in sala operatoria alla undicesima ora di turno senza pause sostanziali e magari con altre 12 ore 36 ore prima (e succede, ahimè….!), allora il problema non è la fallibilità del medico perchè incapace ma è un problema sistemico che crea l’impossibilità di fatto per il medico di operare in maniera lucida.
Cerco di chiudere questo esempio e di andare al punto: la statistica dovrebbe essere considerata come uno strumento di indagine, istruttorio per ulteriori approfondimenti.
Invece troppo spesso ci si affida ciecamente ai numeri.
Nel caso della medicina poi ancora di più perchè troppo spesso, davvero troppo spesso, ne va della vita stessa delle persone ed i numeri, per qualche ragione che io non conosco, sono straordinariamente confortanti.
Dimentichi una cosa: dubitare è la sostanza del metodo scientifico! 🙂
Ne determina l’esistenza stessa! 🙂
per alcuni umiltà è solo una parola e neanche quella che usano di più. hai ragione.
Ciao Piero, non è che ti sei mangiato 2 polli a colazione? Ho stranamente la pancia piena… 🙂
Infatti, questo è un altro elemento per cui la cieca fiducia verso gli esperti è poco saggia.
Siamo troppo complessi per poterci racchiudere in poche semplici parole descrittive.
Non si tratta di non fidarsi e basta. Anzi, se non ci si fida si rischia di andare in ansia per ogni cosa che non possiamo fare noi con le nostre mani (che poi non è detto che è meglio…).
Si tratta solo di avere la consapevolezza della possibilità di errore, che è dovuto a molteplici fattori.
il concetto di analogia copre un campo di esperienze assai vasto che risonde ad un preciso contesto teorico.
Quando, dato un 'modello', espresso da una funzione di trasferimento ( leggi: equazioni che legano gli ingressi, lo 'stato' del sistema e le uscite) … si può scoprire che le stesse equazioni possono descrivere sia un sistema elettico, che un analogo meccanico o idraulico.
Purtroppo la rigorosità del metodo non consente grandi 'voli' ma neanche grandi errori!
Più in generale, invece, è interessante seguire un concetto di 'analogia' più debole che però estende di molto il campo applicativo: Se si seguono i filoni di R&D cosiddetti 'Cutting edge' è possibile vedere le nuove 'tecniche' e le intuizioni' che, in certi istanti, fanno evolvere detti filoni… A questo punto vale fare delle belle 'pensate' su come ipotizzare di estendere il concetto di analogia, ed in definitiva di applicabilità e 'valenza' a tutti gli altri 'temi' di interesse.
Va anche sottolineato che tutto ciò non sempre porta a grandi positività basti pensare alle analogie derivate dalle 'chaos theory' in ambito matematico, che, mutuate in economia, sono risultate causa della presente crisi.
ciao
Antonio
L'esempio è sbagliato perchè una teoria fisica, per esempio, si deve scontrare con le variabili, con le condizioni al contorno, con il ripetersi degli eventi.
Ma in un modo relativamente statico.
Anche se lo tsunami ha inclinato l'asse terrestre, la gravità non è cambiata. Cambia l'angolo di deviazione ma non il principio.
Invece l'economia è fatta di fattori mutevoli e teorie date dall'osservazione. Gli atteggiamenti umani non sono fenomeni fisici o reazioni chimiche.
Quindi secondo me l'esempio è sbagliato ma quello che dici è giusto.
Ciao Piero.
Posso riprendere solo ora.
Ho riletto il mio commento e lo trovo troppo duro. Davvero troppo.
In realtà non ce l'ho con te, visto che (credo? :-)) non sei un politico e che quindi non prendi decisioni anche per me.
Il mio giudizio su QUESTA europa e sul suo strumento per distruggere i popoli del suo sud rimane inalterato ma NON voglio che tu faccia da bersaglio per colpe certamente non tue. Ho visto scene che mettevano il magone…
Hai il diritto di pensarla come vuoi, e spero DAVVERO di sbagliarmi sul nostro futuro.
Se ti ho offeso ti chiedo scusa.
Per me il caso è chiuso
Come da oggetto, ci vuole ben altro per offendere me, puoi stare tranquillo 🙂
Io, però, ci tengo a dire che ti ringrazio sinceramente per questo tuo intervento, lo apprezzo e lo ammiro.
Non ho fatto confusione tra quanto tu fossi accalorato col fatto che tu avessi me in antipatia o giudicassi me per le mie idee (per quanto perfettibili!!!!!!!). Sarebbe infantile confondere queste cose. 🙂
Per il resto, solo il tempo potrà dire chi di noi è stato troppo pessimista, nella speranza che tutti facciano comunque tutto nell’interesse della collettività e non dei singoli. 🙂
Bell’esempio.