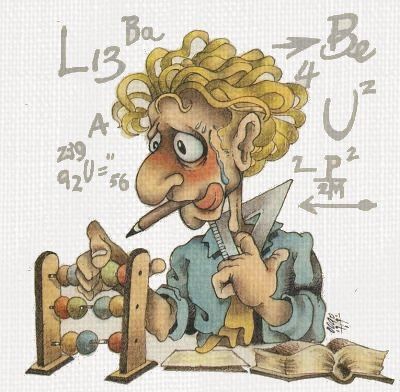
Ipotesi di modellazione matematica del processo valutativo di un individuo nei confronti di qualcuno o qualcosa
Proviamo ad analizzare in termini matematici il processo di valutazione che espletiamo nei confronti di qualcuno o qualcosa e che ci induce a provare apprezzamento, disprezzo o indifferenza per esso. Cominciamo con l’osservare che il nostro giudizio su un dato ente è il risultato complessivo dell’esame di ciascuna delle sue caratteristiche (pregi/difetti). Ad esempio, quali potrebbero essere i parametri con cui valutare un individuo? A me vengono in mente i seguenti:
-
affabilità,
-
intelligenza,
-
onestà,
-
serietà,
-
posizione socio-economica,
-
professionalità,
-
aspetto fisico,
-
cultura,
-
altruismo.
Mentre, per quanto riguarda, ad esempio, un oggetto tecnologico (come, per esempio, un elettrodomestico o un veicolo), i parametri di valutazione potrebbero essere i seguenti:
-
efficienza,
-
prezzo,
-
consumo di corrente o carburante,
-
dimensioni,
-
aspetto/design,
-
facilità di utilizzo,
-
garanzia,
-
durata,
-
necessità di manutenzione.
Qualunque sia il numero totale di tali parametri (che ovviamente varia da ente ad ente), chiamiamolo n.
Il nostro giudizio soggettivo su qualcuno/qualcosa si potrebbe esprimere matematicamente sotto forma di ennupla di valori reali compresi tra -1 e 1, ciascuno da abbinare al rispettivo parametro, ovvero una sorta di “pagella”.
Volendo fare degli esempi, se consideriamo molto attraente una donna, daremo come “voto” 0,8 o 0,9 o anche 1 al suo aspetto fisico, oppure -0,8 o -0,9 o addirittura -1 se esteticamente ci disgusta, oppure 0 se ci lascia indifferenti. In altre parole, ad ogni pregio viene associato un valore positivo ≤ 1, mentre ad ogni difetto (o assenza di pregio) un valore compreso tra -1 e 0. Il “voto” 0 lo riterrei adeguato anche quando non si è in grado di fare una valutazione; ad esempio, attribuirò 0 a “posizione socio-economica” di un individuo se non so nulla in merito alla sua professione, al suo conto in banca e al suo tenore di vita; analogamente, porrò uguale a 0 il parametro “aspetto fisico” riguardante una ragazza che conosco solo telefonicamente e/o telematicamente e di cui nessuno mi ha mai fornito una descrizione fisica. In questo modo, si viene ad individuare il seguente vettore:
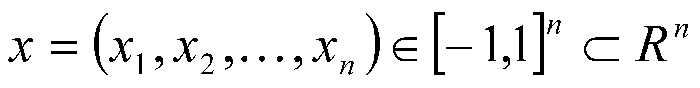
Ciascuno di noi dà più importanza a certe qualità e minore ad altre; pertanto, suggerirei di moltiplicare ciascun per un coefficente assumente valori reali compresi tra 0 e 1. Il valore di sarà direttamente proporzionale all’importanza che attribuisco a ; ai valori 0 e 1 corrisponderanno rispettivamente l’importanza minima (nulla) e massima.
A questo punto, eseguo la sommatoria degli n termini e ottengo:
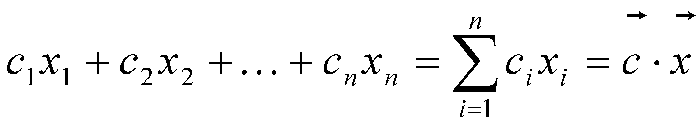
ossia il prodotto scalare dei vettori X e 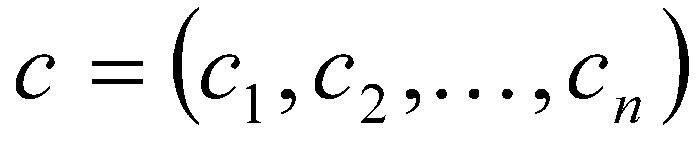 .
.
Tale numero, che è ovviamente compreso tra –n e n, a mio avviso, è un buon quantificatore del grado di apprezzamento di un individuo per qualcuno o qualcosa. Lo potremmo chiamare, ad esempio, G:
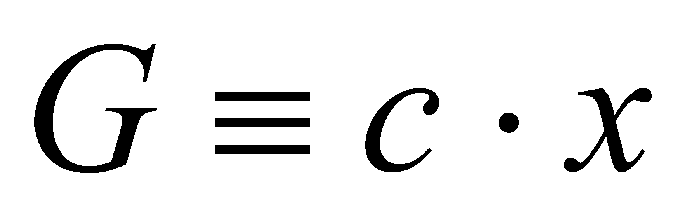
Se chiamiamo a il valutatore e b ciò che egli valuta (oggetto o persona), non è difficile rendersi conto che dipende da a e b, mentre solo da a; di conseguenza, anche G è funzione di a e b:
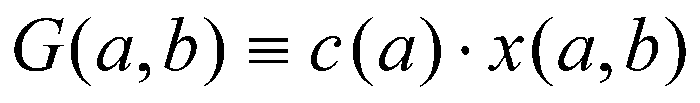
Se b è una persona, mi sembra abbastanza logico ipotizzare l’esistenza di un valore S(a) tale che per G(a, b) ≥ S(a) a provi simpatia per b. Inoltre, se a e b sono di sesso opposto (o anche dello stesso sesso, se vogliamo considerare pure gli omosessuali), mi sembra altrettanto logico ipotizzare l’esistenza di un valore I(a) > S(a) tale che per G(a, b) ≥ I(a) a si invaghisca di b. Analogamente, è plausibile che esista un numero A(a) < S(a) tale che per G(a, b) ≤ A(a) si abbia l’effetto opposto, ovvero a nutra antipatia o addirittura acredine per b.
A, I e S dipendono da a, ovvero varieranno da individuo a individuo, ma presumibilmente dovrebbe essere: A < 0, S > 0 e I ≥ n/2 (personalmente, non credo di potermi infatuare di una donna se G(me, lei) non sia pari almeno a 3n/4, ossia ritengo che il mio I sia ≥ 3n/4). Ciascuno di noi, volendo, può provare a calcolare il G di alcune delle persone che conosce per tentare di fare una stima, anche approssimativa, dei propri A, I e S. Va aggiunto che probabilmente questi 3 valori variano anche nel tempo, dal momento che i gusti, le idee e la personalità di un individuo, in genere, si evolvono; quindi, si dovrà scrivere: A(a, t), S(a, t), I(a, t). Parimenti, anche e dipenderanno dal tempo e pertanto sarà più corretto scrivere:
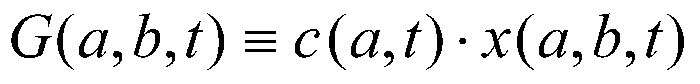
Quest’ultima considerazione ci suggerisce di perfezionare il nostro quantificatore di apprezzamento integrando G(a, b, t) su un intervallo temporale arbitrario 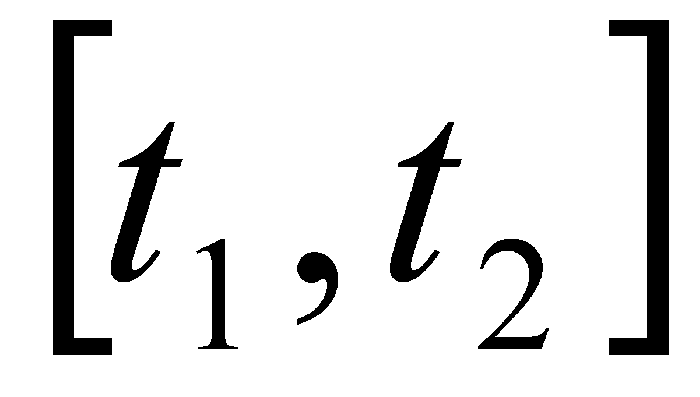 :
:
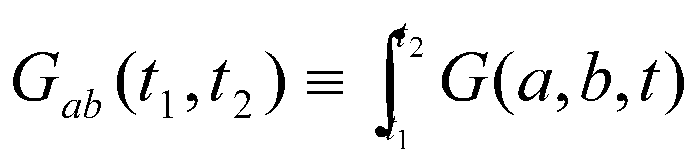
Chiunque sappia cos’è un integrale definito non avrà difficolta a capire che quest’ultima funzione quantifica l’apprezzamento medio di a per b relativo ad un periodo di tempo 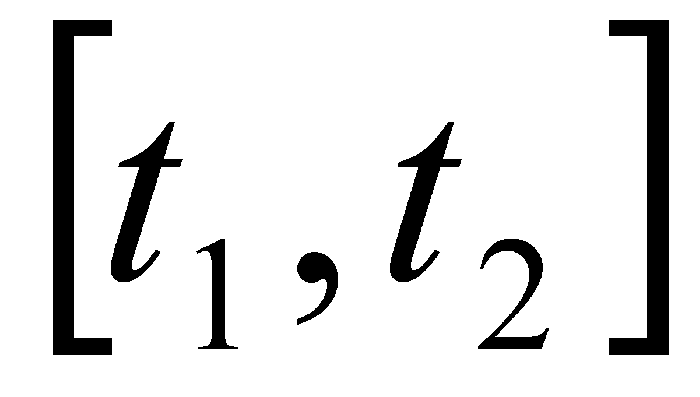 . Si avrà ovviamente:
. Si avrà ovviamente:
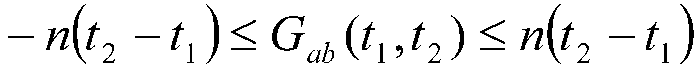
Naturalmente, ciò che ho illustrato non può essere considerato un vero modello matematico (al massimo, può essere definito pseudo modello matematico), principalmente per il fatto che non è supportato dai risultati di alcun test (non è stato condotto nessun test per verificarne la validità); pertanto, si può dire che rimaniamo nell’ambito delle congetture.
Tuttavia, sono convinto che il criterio di valutazione che tutti noi, più o meno consapevolmente, utilizziamo per esprimere un giudizio su qualcuno o qualcosa rispecchi il procedimento matematico da me descritto.


Tempo fa fui chiamato a realizzare un progetto elettromedicale rivolto alla cura del dolore. L’inventore aveva sviluppato tutta la parte teorica e mi aveva incaricato dello sviluppo hardware e firmware. La cura dei dolori avveniva tramite delle forme d’onda particolari, principio simile all’elettrostimolazione dovuta alle onde di Kotz.
Non essendo mio dovere indagare sulla reale efficacia, da buon progettista mi sono limitato a fare il mio mestiere: riprodurre in uscita le forme d’onda richieste.
Cito quanto sopra per introdurre un discorso che l’inventore a suo tempo mi fece.
In pratica sosteneva che noi progettisti elettonici “diamo la vita” alle cose, realizziamo prodotti che popolano il nostro mondo (basti pensare alla robotica)
e che quindi abbiamo una grossa responsabilità essendo dei veri e proprio ‘creatori’.
L’importanza del ragionamento veniva accentuata dall’uso, che noi progettisti elettronici, facciamo della tecnologia. Come ad esempio i computer.
Questo ci differenzia da qualsiasi altro artigiano, rendendoci non solo della sorta di ‘creatori’ ma anche in grado di decidere le sorti del mondo!
Mi diceva: “immagina se in un computer potessimo inserire tutte le variabili umane, si potrebbero prevedere gli eventi!”
Sono passati molti anni e non so se voleva solo impressionarmi (per chiedermi uno sconto) o credeva veramente (ed in che termini) a quanto affermato, ma l’articolo pubblicato sopra mi ha fatto tornare in mente quel ragionamento.
Vale la pena fare una ulteriore riflessione sul tema?
L’articolo offre uno spunto assolutamente originale, complimenti all’autore. Il punto però è: come vengono scelte le variabili che determinano il nostro giudizio? Ognuno ha le proprie 10 e l’incisività della numero 1 e della 10 è una forbice molto ampia…
Salve, la ringrazio dei complimenti. La scelta delle variabili è arbitraria e soggettiva; alle 9 (non 10) che ho elencato per le persone si potrebbe aggiungere ad es. “abilità nel cucinare”, o più in generale “abilità nel fare qualcosa” e avremo tanti parametri in più quante sono le attività umane. Volendo fare un altro esempio, un tamarro presumibilmente metterebbe in cima alla lista il parametro “tamarraggine” o “livello di tamarraggine”. Se ci si riflette un attimo, si comprende facilmente che sulla scelta dei parametri di valutazione influiscono anche i vari contesti: culturale, storico, geografico, ecc.. Questa “aleatorietà” dei parametri in gioco è uno dei motivi per cui il mio non può essere considerato un vero modello matematico.
Completo la mia risposta aggiungendo che occorrerebbe mettersi universalmente d’accordo su quanti e quali debbano essere i suddetti parametri, nonché su quali caratteristiche vadano definite pregi e quali difetti. Dopodiché andrebbero condotti degli opportuni test (il metodo galileiano) e, nel caso in cui i risultati supportassero ciò che ho scritto, allora avremmo un vero modello matematico.
Forse la valutazione delle persone è una pratica che spetta solo alle persone stesse e forse è proprio questo che ci differenzia dalle cose. Apprezzo lo sforzo e, pur per certi versi considerando il modello matematico affascinante, mi sa tanto di test MMPI.
Mi sono fatto persuaso del fatto che tu abbia ragione!
Le variabili non sono infinite ma sono tante e laverità è forse un piccolo
di impredicibilità fa bene, o meglio farebbe bene, nel valutare le
nostre interazioni.
Anche perchè modelli matematici semplificati e quindi, in qualche modo, semplicistici, sarebbero più deleteri che altro.
Se modello deve essere, allora, che sia lungo e ban caratterizzato
l’elenco delle variabili e che sia condivisa una funzione di pesatura
definita per ciascuno di essi.
La matematica è sempre un portento da utilizzare in molti campi, nei sistemi di controllo, per esempio, ho visto molti matematici lavorare in stretto contatto con ingegneri per la definizione di progetti. Da un lato la teoria matematica e dall’altro l’ingegnerizzazione.